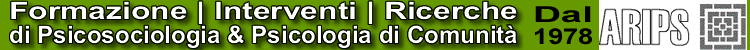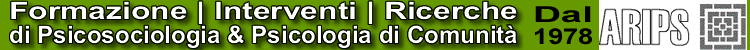|
Definire l’umano
nell’Era degli Automi e dei Borg (in margine al 28°
Lab ARIPS*)
(G.Contessa / Agosto 2002)
1. Dalla
mitologia alla realtà
Tutta la storia dell’umanità è costellata di miti
relativi alla trasfigurazione del corpo e a tipologie di
esseri per metà umani e per metà qualcos’altro. Il
dio Pan e il diavolo, il Minotauro ed i centauri, le Sirene
di Ulisse, gli dei egizi, il bestiario orrifico medievale,
fino alle stampe del Sette e Ottocento che raffigurano i
bersagli della satira in forme animali. L’immaginario
ha sviluppato un universo di corpi ibridi, mutanti, trans-specifici,
mentre in concreto si operava la trasformazione dei corpi
con tatuaggi, piercing, mutilazioni o più semplici semplici
trucchi, ornamenti e abbigliamenti. La tradizione ha maggiormente
concentrato la sua attenzione su umani che si animalizzano,
mentre la modernità ha puntato di più sugli animali e le
cose che si umanizzano (da Alice a Walt Disney, da Orwell
al Signore degli Anelli).
Questa tensione ha a che fare
con problemi come la colpa e la morte. La trasmutazione
del corpo allucina una evasione dal senso di colpa inerente
l’umano, e dal timore della morte intesa come punizione
per la colpa. Se il corpo può diventare un'altra cosa, se
ogni cosa può diventare corpo umano, l’uomo è sollevato
da colpa e mortalità, così come gli esseri animali o inanimati
coi quali si ibrida.
Sono la tarda Modernità e più
ancora il nascente Evo Immateriale ad inoltrarsi in concreto
nell’annebbiamento dei confini dei corpi, dei sessi,
delle specie. I confini fra i mondi umano, animale, inanimato
e meccanico subiscono una metamorfosi “quantica”
che insedia la probabilità al posto della certezza, percorrendo
quattro strade. La prima direttrice è stata quella medica
che mediante vaccini, protesi, chirurgia plastica, terapie
ormonali, trapianti, manipolazioni genetiche e clonazioni,
opera una progressiva mutazione del corpo.
La seconda direttrice è quella
tradizionale dell’estetica, ma amplificata dall’industrializzazione
degli interventi: fitness, trucco, ornamenti, abbigliamento,
tatuaggi, piercing e mutilazioni. Il crescente fenomeno
del transessualismo è una concreta modificazione dei corpi
per via medica ed estetica.
La terza è la via chimica. Dalle
pillole antifecondative agli allucinogeni, dagli anti-depressivi
ai sedativi pesanti usati in psichiatria, dalle pillole
dimagranti agli anabolizzanti: la ricerca degli stati alterati
della mente e del corpo, tradizionalmente affidata all’erbario
artigianale ed esoterico, è diventata consumo industriale
di massa.
La quarta e più recente direttrice
è quella meccanica e cibernetica. Dai pace makers agli stimolatori
elettrici dei tetraplegici, è in pieno sviluppo la ricerca
di protesi e sussidi “intelligenti”che ridiano
al corpo funzionalità normali o addirittura ampliate. In
parallelo sta crescendo la ricerca di macchine “umanizzate”:
dagli animali robot giapponesi ai computer che parlano,
dai software in grado di “chattare” a quelli
capaci di scrivere poesie e racconti, suonare musiche e
dipingere.
2.
Come definire l’Umano?
Questa progressiva riduzione
dei confini fra umano e organico (con la chimica), animale
(coi trapianti), inorganico (con la cibernetica) mette in
difficoltà la definizione e il riconoscimento. Un essere
coi reni trapiantati da un suino, un pacemaker, un innesto
elettro-muscolare e un arto meccanico, come può essere definito?
E come considerare un robot rivestito da un’avanzata
simulazione epidermica e in grado di parlare, vedere, apprendere
? Il transessualismo riduce le differenze di genere (per
ora non si è arrivati al trapianto d’utero), e le nuove
frontiere stanno riducendo le differenze di specie (umano,
animale e vegetale). E’ molto avanzata la ricerca sul
maialino per i ricambi d’organo. Già siamo riusciti
a produrre campi di “tabacco luminoso”, innestando
geni di lucciole in quelli del tabacco. Non servirà molto
tempo per avere un innesto di lavanda nei geni umani, e
ottenere un “sudore profumato”. Ma alle viste
c’è anche il superamento del confine fra mondo organico
ed inorganico. Con l’innesto cerebrale di chip, qualche
non vedente è tornato a vedere. Con innesti muscolari di
elettronica, gambe e braccia tornano a muoversi fluidamente.
E se l’ibridazione dei corpi con metallo e software
ha dei limiti (Robocop è molto lontano), più vasto è l’orizzonte
apposto. L’umanizzazione dei sistemi di metallo e
software tramite applicazioni sempre più sofisticate di
memoria, percezione, verbalizzazione, reazione cinestetica
e calcolo algoritmico, sta facendo passi da gigante.
I dispositivi corporei di esplorazione
della realtà virtuale, già piuttosto avanzati, creano una
realtà a partire dal corpo umano. Non è difficile pensare
che arriveremo presto al contrario: dispositivi ambientali
a partire dai quali si potranno creare corpi.
Vita artificiale e simulazione
del linguaggio umano, in forma scritta o verbale, sono ad
uno stadio avanzato: dai boids (forme simil-animali che
si muovono sullo schermo secondo programmi di di partenza,
ma che sviluppano una “vita” autonoma) ai chatbot
(software di conversazione), ai videogames come simcity,
che simulano una comunità vivente. Ma ora la frontiera è
tridimensionale, col passaggio della cibernetica ai problemi
di mimica e cinestesìa. Il cane Aibo della Sony è già banale.
Honda ha creato Asimo, un droide dall’aspetto umano
che può fare da guida e custode nei musei. La Sony ha replicato
con SDR-3X che cammina e riesce a stare su una gamba sola.
Cyborg è un robot che si muove seguendo fonti luminose.
Il MIT sta lavorando su droidi “mimici” cioè capaci
di numerose espressioni facciali.
Ad uno stadio avanzato di queste
nuove frontiere dell’Immaterialesimo, come definiremo
l’Umano? Il problema sarebbe semplice se già oggi disponessimo
di una definizione accettabile. Ma così non è. La esperienza
che mi ha offerto il Lab Umanauti (*) è stata molto ricca
di tentativi quanto povera di soluzioni accettabili.
3.
Identità soggettiva e identità sociale
La prima questione che si è
posta nel lab e che ha reso il lavoro molto arduo, è quella
del rapporto fra soggettività e socialità. Ognuno di noi
dichiara di “sapere” di essere umano, per il fatto
di avere un corpo, dei ricordi, un’immaginazione ed
una coscienza. La particolare simulazione del Lab tuttavia,
rendeva inaccettabili questi argomenti: primo, perché il
web esclude il corpo; secondo, perché esisteva l’ipotesi
della menzogna. D’altronde è assurdo assegnare al corpo
ed all’ autodichiarazione una funzione dimostrativa,
specie in un’epoca ottica, spettacolare e illusionistica
come l’attuale. Effetti speciali, realtà virtuale,
ologrammi, materiali sofisticati, consentono una manipolazione
oculare, uditiva ed anche tattile al punto che i nostri
sensi sono vistosamente parziali e insicuri. Non è impresa
impossibile, per esempio, se si utilizza una webcam per
verificare l’identità dell’interlocutore, far
“vedere” un filmato anziché il corpo reale dell’interlocutore.
La vista e l’udito sono i sensi più fragili di fronte
all’inganno. L’olfatto è uno dei sensi in via
di sparizione a causa dell’ossessione tutta moderna
contro la naturalità. Il gusto e il tatto sono sensi importanti,
ma usati solo nelle relazioni molto intime.
La situazione del Lab poneva
i partecipanti in una condizione pre-moderna, quando veniva
considerata vera e reale, qualsiasi cosa venisse dichiarata
o raccontata. La tradizione orale, le limitazioni epistolari,
le creazioni artistiche hanno assegnato per secoli un valore
di verità a molte cose rivelatesi nel tempo fantastiche,
mitiche o false tout court. Col risultato di rendere indistinto
il confine fra vero e falso, umano e immaginario. L’aggravante
è che, mentre nell’era pre-moderna vigeva il “pregiudizio
di verità” (una cosa raccontata è vera fino a prova
contraria), la Modernità è cresciuta basandosi sul “pregiudizio
di falsità” (una cosa è vera solo se è verificata,
o meglio, falsificata). L’insieme di confini indistinti
fra vero e falso e fiducia, moltiplica le potenzialità;
la coesistenza di confini indistinti e dubbio, paralizza,
impaurisce e rende paranoici.
L’umano non può dunque
essere riconosciuto dai sensi, se usiamo i criteri moderni.
Ma nemmeno può bastare l’autodichiarazione. Il Lab
ha messo in gioco il paradigma investigativo. La situazione
era simile a quella dei classici gialli, nei quali tutti
dichiarano di essere innocenti. Se abbiamo il dubbio di
un disegno menzognero, ogni affermazione diventa inaccettabile
se non è suffragata da un riscontro. La situazione del
Lab era anche simile, sia pure in termini rovesciati, al
famoso test di Turing. Come è noto, il test consiste nel
far sottoporre da un soggetto “cieco” delle domande
a due interlocutori: uno umano e l’altro informatico.
Il computer è tanto più intelligente quanto più l’interrogante
tarda a riconoscere le sue risposte rispetto a quelle umane.
All’interno del Lab è anche
stato fatto un piccolo test di Turing, usando poesie create
da umani e poesie generate da appositi software: i partecipanti
non sono stati capaci di cogliere la differenza. Una cosa
simile è avvenuta relativamente ai sessi. Il lab ha registrato
l’incapacità dei partecipanti di riconoscere, attraverso
le sole interazioni, il sesso reale degli altri. I sensi
dunque, e l’autoaffermazione, sono risultati criteri
fragili o imprecisi per il riconoscimento dell’identità.
La stessa impraticabilità è
attribuibile al riconoscimento interpersonale o reciproco.
Spesso nel Lab qualche partecipante ha dichiarato di sentire
“umano” qualcun altro, ma tale dichiarazione veniva
facilmente inficiata dall’ipotesi della menzogna o
dell’errore. Anche perché a sua volta il dichiarante
era sottoposto al dubbio di essere un software. Nel paradigma
investigativo, non è accettabile l’alibi fornito da
chi a sua volta non ha alibi, o non è un testimone credibile.
La stessa cosa vale per i riconoscimenti reciproci: io
penso che lui sia umano e lui pensa che lo sia io. Una simile
attribuzione reciproca, alimenta il dubbio dell’alleanza
complice. La validazione interpersonale non ha valore sociale:
tutt’al più identifica un’isola, un’aggregazione
marginale, a rischio di esclusione.
La conclusione è che l’identità
è necessariamente un’attribuzione sociale: siamo ciò
che la grande maggioranza del contesto pensa che siamo.
Il criterio, da scientifico diventa politico, perché il
consenso prevale sulla verità. Il che implica una messa
in crisi dello scientismo moderno, la cui sfida è stata
appunto quello di far prevalere la verità sulla politica.
Tolomeo torna a vincere su Galileo.
La cosa non è priva di conseguenze
e di rischi. Per esempio, le creazioni fantastiche e mitologiche,
le falsificazioni manipolatorie, le allucinazioni e i deliri,
diventano imbattibili se il consenso prevale sulla verità.
Un recente B-movie televisivo era incentrato sulla storia
di un piccolo villaggio dell’anonima campagna Usa,
nel quale prosperità, coesione comunitaria e sicurezza sociale
erano garantiti dal sacrificio annuale, per lapidazione,
di un membro estratto a sorte. L’eroe della storia
che, dopo mille peripezie, denuncia il fatto all’FBI,
finisce in ospedale psichiatrico perché la comunità assassina
è abbastanza abile da coprire le tracce e perché lui non
viene creduto. Da qui nasce l’attuale timore di molti,
circa il problema dell’eutanasìa, della genetica, o
di simili problemi che toccano l’esistenza alle radici.
Se il riconoscimento della vita o della morte, dell’umanità
e della salute, come della normalità, viene assegnato a
organismi sociali (comitati etici, équipes mediche, authorities,
ecc.) chi ci difenderà dai deliri, dalle prevaricazioni
o dalle ideologie ?
D’altra parte è vero che
il potere della società nel riconoscimento identitario si
pone in ogni campo, compreso quello dell’attribuzione
di umanità. E’ costante la tentazione di definire “mostri”,
cioè non umani, i colpevoli di delitti efferati o socialmente
inaccettabili. Su un piano meno drammatico, l’essere
artisti, o professionisti qualificati, o buone madri o quant’altro
è puntualmente condizionato dal riconoscimento sociale.
Non è un caso che il XXI secolo sta vedendo l’esplosione
di nuovi ceti di intermediazione specializzati nei processi
di certificazione, accreditamento, qualità, brevetto. La
società pre-moderna aveva la competenza del riconoscimento
in casi particolari e limitati. La società immateriale sta
avviandosi verso regimi di certificazione onnipervasivi.
Arriveremo a dover ottenere un certificato di umanità?
4.
Identità dichiarata, comportamenti visibili
Un’altra questione esplorata dal
Lab è il conflitto sempre più esplicito fra le dichiarazioni
di identità e la coerenza dei comportamenti visibili. Ogni
individuo ha un’immagine di sé, crede fermamente di
essere una certa persona. Questa costruzione non sempre
ha a che fare coi comportamenti che esprime realmente, a
volte addirittura né è in aperto contrasto. Ciò per molti
deriva da una scarsa consapevolezza, per altri da ridotte
capacità di controllo. Ma per tutti il problema nasce dalla
soggettività del proprio linguaggio e sistema identitario.
Chi guarda può non vedere una coerenza fra identità dichiarata
e comportamento visibile, che invece per il soggetto è
evidente. Durante il Lab spesso i partecipanti facevano
dichiarazioni relative alle sensazioni o ai sentimenti
(tensione, empatia, aggressività) che provavano, oppure
affermazioni riguardanti aspetti della personalità (creatività,
autonomia, solidarietà) che avevano. Altrettanto spesso,
altri partecipanti dichiaravano di non vedere nei comportamenti
o nelle comunicazioni concrete, i sentimenti o i tratti
di personalità dichiarati. Il soggetto vaneggia? Finge ?
O si illude? Forse tutte e tre le cose, ma forse è anche
vero che gli interlocutori non ascoltano, non osservano,
rifiutano i messaggi, li fraintendono per incapacità o malafede.
Ma più facilmente è vero che il soggetto si comporta in
modo che ritiene coerente con le dichiarazioni che fa, secondo
un linguaggio proprio, che per gli altri risulta incomprensibile
o equivocabile.
Un esempio. Un partecipante dice di non
essere d’accordo con un altro, poi si scusa per essere
stato aggressivo. Infine conviene con le proposte dell’altro.
Questa sequenza può essere interpretata in –n- modi
possibili. Per il dichiarante la sequenza dimostra la coerenza
con quella personalità autonoma e sensibile che ritiene
e afferma di avere. Per l’altro la sequenza mostra
ostilità, incapacità di gestire il senso di colpa, desiderio
di quieto vivere: una personalità dipendente e invidiosa.
Un altro esempio. Alcuni partecipanti
si presentano in modo tradizionale, con nome, professione
e città di residenza. Qualcuno fa notare che questa presentazione
non si concilia con la dichiarazione, fatta da molti, di
essere “creativi”. Ma qualcuno replica che considera
spregiudicato e anticonformista l’aver omesso, nella
presentazione, il titolo di studio.
Siamo ciò che pensiamo di essere, più
ciò che la comunità crede che siamo. Fra i due poli si collocano
comunicazione e negoziazione, due processi il cui limite
consiste nell’aver bisogno di un linguaggio comune.
Il paradosso della comunicazione è che “per mettere
in comune”(comunicare) qualcosa occorre “avere
in comune” qualcosa. La comunicazione richiede comunicazione,
in un processo infinito a ritroso la cui difficoltà aumenta
nelle fasi storiche di frantumazione, come l’attuale.
L’identità umana dunque richiede un riconoscimento
sociale, il quale deriva da una comunicazione che a sua
volta richiede un’identità umana. Se in questi loops
psico-logici si insinua anche il dubbio della menzogna,
il problema sembra irresolubile.
5.
Cosa ci rende umani ?
Esiste qualcosa che possiamo ritenere
prova o sintomo specifico dell’umano? La differenza
fra umano e animale o vegetale è attribuita, fra l’altro,
alla simbolizzazione, all’individuazione, all’accumulazione
culturale. La differenza fra umano e inorganico è attribuita
alla riproduzione. Ma qual è la differenza fra umano e umanoide?
Fra umano e cibernetico? Le prossime frontiere dei processori
sono due. La creazione di qubit, basati sul probabilismo
quantico. E la creazione di processori con materiale biologico.
Quando il nostro hardware avrà un cuore fatto di due atomi,
o del dna di ratto, oltre ad essere veloce come il nostro
cervello, sarà capace di sfumature, cioè di vita artificiale
e pensiero umano sofisticati. Dove possiamo fissare il confine
dell’umano, in un corpo manipolato geneticamente e
fatto vivere con protesi, trapianti e macchine ?
Il Laboratorio ha offerto molte idee
in proposito, ma nessuna apparentemente decisiva.
La prima è quella che viene dal film
“Blade Runner”: i ricordi, dunque le emozioni
ed i sentimenti definiscono l’umano. Dopo “Blade
Runner” è venuto Total Recall, la cui vicenda nasce
da un’agenzia di viaggi che offre innesti di memoria
su misura e comprendenti ogni emozione “a menù”.
Si tratta solo di films, ma anche di profezìe. Che potranno
avverarsi quando la IBM terminerà il computer che ha iniziato
a costruire nel 2001: capace di 100 trilioni di operazioni
al secondo. Come riconosceremo la telefonata di cordoglio
di un parente da quella fatta da un software capace di usare
una voce rotta dal pianto e che rievoca episodi reali della
vita del defunto?
La seconda ipotesi riguarda la poesia,
la fantasia, l’arte, l’immaginazione. Secondo
questa idea solo l’umano è capace di parlare di cose
che non ci sono, di creare associazioni o simboli astratti,
raccontare emozioni senza parole convenzionali. Purtroppo
questa ipotesi è già oggi confutata dai software che creano
poesie, racconti, discorsi, quadri, musiche, del tutto
originali o “alla maniera di” imitando perfettamente
uno stile artistico.
La terza idea, più avvincente, concerne
l’umorismo. Nessuna altra specie ride. L’umano
ride e fa ridere utilizzando o situazioni ripetitive ma
“buffe” (cadute, torte in faccia, difetti fisici,
ecc.) o associazioni paradossali, contrasti, provocazioni.
Il riso nasce da uno sgambetto logico, da una sorpresa o
da uno piazzamento; oppure nasce dalla soddisfazione di
vedere capitare ad altri ciò che temiamo; o infine dalla
attivazione di ricordi o bisogni infantili, associati a
gratificazioni. Il limite del riso come definizione dell’umano
risiede nella sua élitarietà e fragilità. Il comico è un
dialetto: vale solo fra coloro che conoscono bene la cultura
e la lingua. Ed è anche una dimensione fragile ed effimera:
richiede un preciso contesto, senza il quale sparisce. Se
arrivassimo a definire l’umano con l’umorismo
e il riso, rischieremmo di non considerare umano chi non
fa ridere o non ride, magari solo perché non ha il linguaggio
giusto (verbale, gestuale o mimico), o perché il contesto
non è adatto. Senza contare che immagazzinando in un programma
tutte le battute di Totò, Groucho Marx o Woody Allen, potremmo
strappare una risata a chiunque.
Il problema della distinzione fra umano
e cibernetico sta nel fatto che il secondo mondo è interamente
figlio del primo. I mondi animale, vegetale e minerale sono
stati creati o si sono sviluppati prima e senza quello umano.
L’universo informatico è invece interamente prodotto
dal genere umano a sua immagine e somiglianza. Anche manufatti
ed artefatti sono prodotti umani, ma, sia pur tecnologicamente
o artisticamente sofisticati, sono limitati alla sfera materiale,
cioè sono sempre “cose”. Anche un libro e un quadro
sono imprigionati nei loro supporti materiali. La cibernetica
è un prodotto umano smaterializzato, che ancora si radica
su una base materiale, ma che imita gli strumenti umani
immateriali: intelligenza, memoria, parola, gesto, emozioni,
apprendimento. L’umano produce un nuovo universo immateriale
a sua somiglianza: in che modo potrà distinguersi da esso
?
6.
L’ipotesi della “libertà di fare male”
e il paradosso dell’Angelo
L’ipotesi che il Lab mi
ha suscitato è che l’umano si riconosca essenzialmente
dal Male. Non solo dalla libertà di fare il male, ma anche
dalla sua concreta attuazione. La libertà di fare male che
non si attua mai, è indistinguibile dall’omologazione
impersonale. L’errore, il difetto, la mancanza, il
peccato, la trasgressione, la perversione, i vizi sono l’estremo
confine dell’umano. La sua frontiera esclusiva; il
segno distintivo della sua unicità di specie sul Pianeta
Terra. L’umano è l’unica specie capace di fare
il Male, per il gusto di farlo o per danneggiare qualcuno.
Il negativo, il diabolico, la cattiveria, la sgradevolezza,
la viziosità: tutto ciò che danneggia se stesso o il mondo
(dai simili alle montagne) è tipicamente umano. L’umano
di definisce e riconosce per ciò che non va in lui. Gli
animali e le piante, come i sassi, sono programmati per
seguire il loro destino e la loro funzione sul pianeta.
Non dirottano, non trasgrediscono; seguono le leggi della
natura. L’umano ha una cultura e questa prevede la
distruttività, auto o etero. L’umano ha la libertà
di fare il male e si definisce come umanissimo proprio nel
farlo.
Questa idea contraddice il senso
comune che attribuisce al male qualcosa di mostruoso, estraneo
all’umano, lontano dalla specie. Ma essa apre una contraddizione
anche maggiore. Quella di una specie che si definisce per
il negativo, ma che mette al centro della sua cultura gli
sforzi per superarlo. Come se l’umano avesse la missione
di trascendere da sé, negarsi, evaporare dalla sua natura.
Molti delitti o trasgressioni vengono spesso definiti come
“contro natura”, a partire dalla illusione che
il male sia “mostruoso”. In verità i delitti e
le trasgressioni sono semmai “contro cultura”,
perché la natura dell’umano è invece intrisa di negativo
e la cultura è appunto il guardiano del male. Chiamerei
“paradosso dell’Angelo” questo destino dell’umano
di definirsi per il diabolico, ma di dover negare la propria
natura: chiamato a diventare angelo, quindi meno umano.
Chi indica come compito principale del transito sulla terra,
quello di migliorarsi e migliorare il mondo, affinare la
“scultura di sé”, implicitamente ammette la condanna
dell’umano a negarsi, negando il suo negativo.
La libertà di fare male è speculare
alla libertà di fare bene che è pure un tratto dell’umano,
anche se questa seconda libertà si concreta nella sua negazione.
La libertà di fare bene si esprime facendo male.
7.
Cosa sarebbe un cyborg malefico?
L’ipotesi del male può
essere falsificata, se pensiamo all’idea di creare
un borg o droide capace di fare male. Asimov ha eliminato
questa ipotesi fissando, fra le sue leggi della robotica,
l’impossibilità per gli automi di danneggiare l’umano.
Ammettendo di voler ignorare questa legge, un computer programmato
per fare il male eliminerebbe il confine fra umano e informatico?
La risposta al quesito è stata esplorata da molta letteratura
dal Golem a Frankenstein. Un artefatto che possedesse la
“libertà di fare male”, riprodurrebbe il mito
di Lucifero rivoltandosi contro il suo creatore. Tale libertà
sarebbe caotica e incontrollabile, cioè non traducibile
in algoritmi, non limitabile da divieti programmati. Tuttavia
questo carattere, se fosse accompagnato dalla libertà di
far seguire il bene al male, assimilerebbe l’automa
all’umano.
Un computer che invece avesse
una programmazione per fare il male in modo ciclico, reattivo
a certe condizioni o anche randomizzato, non sarebbe “libero”,
quindi non sarebbe umano. Lo stesso discorso varrebbe per
un borg malefico per “errore”. Il bug lo condannerebbe
ad un “male coatto”, lontano dall’umana libertà
di fare male.
*NOTA: Il Laboratorio
di Dinamiche di Gruppo e di Comunità “UMANAUTI”
si è tenuto sul web dal marzo al giugno 2002. La simulazione
si basava sui seguenti elementi:
I partecipanti dovevano identificare eventuali
borg sabotatori infiltrati
Per identificare i borg occorreva definire
l’umano e in non umano
L’attività era gestita da software apposito, dichiaratamente
non umano
|