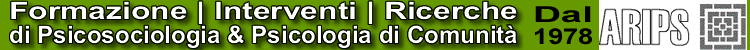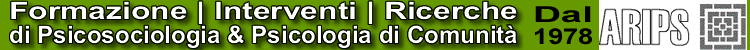|
I
DIRITTI DEL CONSUMATORE
A cura della Dott.ssa Rosa
Barbano Di Maggio (esperto della Qualità e della
Sicurezza)
La legge 30 luglio 1998 n. 281 disciplina
i Diritti dei consumatori e degli utenti. Tale norma,
all’articolo 1 (Finalità ed oggetto della Legge),
stabilisce che:
"1. In conformità ai princìpi
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità
europee e nel trattato sull'Unione europea nonché
nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti
e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi
dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la
tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva
e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire
tali finalità, anche attraverso la disciplina dei
rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti
e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità
dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e
ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed
equità nei rapporti contrattuali concernenti beni
e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico
tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza".
Questa norma rispecchia a pieno le cinque
categorie di diritti fondamentali che stanno alla base
della politica comunitaria in materia di tutela, e cioè:
diritto alla tutela della salute e della sicurezza, degli
interessi economici, diritto al risarcimento del danno,
all’informazione ed educazione, diritto di rappresentanza.
Risulta chiaro, quindi, che i Diritti
riconosciuti al consumatore sono:
- Diritto alla Sicurezza ed alla Qualità degli
alimenti
Questo fondamentale diritto si esplica
nella fase precedente alla vendita del prodotto stesso
e riguarda, fondamentalmente, il processo produttivo.
Molteplici sono le normative, sia "Orizzontali" (cioè
applicabili a tutti i comparti) che "Verticali" (cioè
elaborate per singoli e specifici comparti) in vigore
volte alla tutela della salubrità degli alimenti
e, di conseguenza, della salute del consumatore finale.
Tutto quello che le norme pongono come
"obbligo" del produttore si trasforma in "diritto" per
il consumatore finale.
Tra le maggiori innovazioni normative
intervenute nel nostro sistema giuridico, ancora una
volta in attuazione di Direttive comunitarie, si ha
il D.Lgs. 155/97 (Attuazione delle Direttive 93/43/CEE
e96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari),
che ha introdotto un innovativo sistema di c.d. Autocontrollo
igienico, sulla base del metodo H.A.C.C.P. (Hazard Analisys
and Critical Control Point), cui si accennerà
brevemente in seguito.
- Diritto ad avere un’adeguata informazione e una
corretta pubblicità
Garantita la salubrità dell’alimento,
il produttore deve garantire che lo stesso sia posto
in vendita nel rispetto delle norme che tutelano il
fondamentale diritto dei consumatori alla veridicità
di quanto riportato sulle etichette e sugli imballaggi
e di quanto diffuso con i mezzi di comunicazione di
massa. E’ questa, forse, la fase più critica
per il consumatore che, di fronte alla scelta del prodotto
da acquistare, diventa bersaglio facile di messaggi
pubblicitari provenienti da attenti e sofisticati studi
di marketing.
Anche in questa fase, successiva alla
produzione, è intervenuto il legislatore, comunitario
prima e nazionale poi, con una serie di norme che disciplinano
le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari
e le forme di pubblicità ammissibili. Tra queste
norme, di particolare importanza è il D.Lgs.
27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione delle Direttive
98/395/CEE e 98/396/CEE concernenti l’etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari) recentemente innovato dal D.Lgs. 25
febbraio 2000 n. 68 (Attuazione della Direttiva 97/4/CE
che modifica la Direttiva 79/112/CEE, in materia di
etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari destinati al consumatore finale).
- Diritto ad una Educazione al consumo degli alimenti
Una fase ancora successiva alla vendita
riguarda l’utilizzo domestico dei prodotti alimentari
acquistati: il consumatore, per il legislatore, ha un
diritto fondamentale ad essere informato su come scegliere,
conservare e preparare gli alimenti, al fine di garantire
che, anche nella fase propriamente "privata" del trattamento
degli alimenti, questi non diventino mai potenzialmente
idonei a mettere in pericolo la salute dei consumatori,
soprattutto di quelli "speciali", cioè particolarmente
esposti al rischio di intossicazioni alimentari.
Questo punto è particolarmente
cruciale ed, in sostanza, coinvolge non solo il produttore
(che deve indicare sulle confezioni termini e modalità
di conservazione e preparazione degli alimenti), ma
anche e soprattutto gli organismi pubblici che hanno
l’obbligo di promuovere una campagna di educazione alimentare
a tutti i livelli, come precisato anche nel D.Lgs. 155/97,
sopra citato, all’articolo 6 (Educazione sanitaria
in materia alimentare - 1. Il Ministero della sanità,
d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento
e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove
campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria
in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa
con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole
di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti
di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito
delle attività didattiche previste dalla programmazione
annuale).
A livello comunitario e nazionale si
sta portando avanti una campagna di "Sicurezza alimentare",
consultabile su internet alla pagina http://www.sicurezzalimentare.it.
- Diritto alla Correttezza ed equità nei rapporti
contrattuali
Particolarmente sentito, anche nel
settore alimentare, è il problema prettamente
giuridico, della tutela del c.d. "contraente più
debole", cioè del consumatore che, di fatto,
si trova di fronte a prezzi e condizioni contrattuali
già imposte dal produttore/venditore che può
solo accettare e rifiutare, ma non "contrattare".
Ciò appare ancora più
evidente nel settore alimentare, nel quale non esiste
una vera e propria fase "contrattuale", ma è
il produttore che definisce unilateralmente le condizioni
di vendita che il consumatore può solo accettare
o rifiutare.
Per questo motivo risulta indispensabile
ed assolutamente necessario porre molta attenzione nella
fase di acquisto dei prodotto alimentari, considerato
che il contratto si perfeziona con il pagamento del
prezzo e la consegna della cosa.
- Diritto alla promozione e sviluppo di associazioni
libere, volontarie e democratiche tra consumatori
Proprio per la necessità di
tutelare i consumatori, la legislazione comunitaria
e nazionale promuove la promozione e lo sviluppo di
associazioni dei consumatori che, con i necessari strumenti
giuridici, possano fornire il loro supporto ai consumatori
in settori particolarmente "a rischio", tra i quali
quello alimentare.
- Diritto a che l’erogazione dei servizi pubblici
avvenga secondo gli standard di qualità ed efficienza.
Naturalmente la natura pubblica dei servizi
non esonera i gestori dal tenere comportamenti tali da
garantire gli standard di qualità ed efficienza
dei prodotti o dei servizi, così come la gratuità
od onerosità non può influire sulla salubrità
degli alimenti.
LA LEGISLAZIONE VIGENTE
Il settore alimentare contempla un corpus
normativo vastissimo che copre tutte le fasi produttive
e distributive di una svariata quantità di alimenti.
La questione della tutela dei consumatori
si incentra sulle problematiche dell’etichettatura, della
pubblicità e dei prezzi dei prodotti alimentari;
della salubrità degli alimenti; del diritto all’informazione
ed al risarcimento per danno causato da prodotti difettosi;
i testi di riferimento fondamentali sono:
D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 (Attuazione
della Direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità
ingannevole)
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione
delle direttive 89/395/CEE ed 89/396/CEE concernenti l’etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)
Circolare 27 aprile 1993 n. 140/93. D.
Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109. Etichettatura dei prodotti
alimentari. Sent. N. 401/92 della Corte costituzionale.
D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione
delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene
dei prodotti alimentari)
D.P.R. 23 agosto 1982 n. 903 (Attuazione
della Direttiva 79/851/CEE relativa all’indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione
dei consumatori)
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (Attuazione
della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo
15 della Legge 16 aprile n. 1987 n. 183)
Legge 10 aprile 1991 n. 126 (Norme
per l’informazione del consumatore)
D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 73 (Attuazione
della Direttiva 87/357/CEE relativa ai rpdotti che, avendo
un aspetto diverso da quello che sono in realtà,
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori)
D.M. 8 febbraio 1997 n. 101 (Regolamento
di attuazione della legge 10 aprile 1991 n. 126, recante
norme per l’informazione del consumatore).
L’ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
L’etichetta rappresenta l’elemento fondamentale
sia per il produttore che per il consumatore: per il primo
è un fondamentale strumento di comunicazione (insieme
al packaging); per il secondo è la prima fonte
di informazione sul prodotto che ci si accinge a comprare.
La fondamentale norma di riferimento
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è
il D.Lgs. 109/1992, che attua alcune direttive comunitarie.
Le norme d’etichettatura dei prodotti
alimentari sono state contemplate, in via generale, nell'ambito
della disciplina igienica della produzione e del commercio
dei prodotti alimentari, in particolare nell'articolo
8 della legge 30 aprile 1962 n. 283. Per tale motivo ad
esse è stata sempre attribuita una finalità
esclusivamente igienico-sanitaria, in quanto ritenute
destinate alla tutela della salute pubblica. Questa concezione,
con il passare degli anni e con la creazione della CEE,
ha subito una sostanziale modifica soprattutto a seguito
della politica comunitaria nel settore della legislazione
alimentare, nel quale le norme dirette alla protezione
della salute pubblica sono separate da quelle dirette
ad assicurare l'informazione dei consumatori e la lealtà
e la trasparenza delle transazioni commerciali. In tale
nuova concezione la materia dell'etichettatura dei prodotti
alimentari assume una funzione soprattutto di natura tecnico-commerciale
pur potendo avere anche finalità d’ordine sanitario,
in particolare a fini di controllo.
L'etichettatura dei prodotti alimentari
rientra nel più vasto campo dell'etichettatura
delle merci, prevista per consentire al consumatore di
fare scelte oculate e per imporre agli operatori economici
la lealtà commerciale. La necessità che
i rapporti commerciali siano improntati a lealtà
e correttezza non è una caratteristica dello Stato
italiano, ma di tutte le legislazioni dei Paesi civilmente
evoluti.. E' da evidenziare, tuttavia, che la realizzazione
delle etichette non sempre è un'operazione facile,
soprattutto quando si è condizionati dalla fantasia
e dalla tradizione.
Le fondamentali indicazioni che devono
essere riportate in etichetta sono:
- Denominazione esatta
- Ingredienti (in ordine decrescente per quantità)
- Additivi presenti nel prodotto
- Quantità
- Modalità di conservazione
- Modalità di consumo
- Data di scadenza o termine minimo di conservazione
- Nome del produttore o del distributore
- Luogo di produzione
- Lotto di appartenenza del prodotto
- Altre indicazioni (in base all’alimento)
Nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 322/82 fu previsto l'obbligo di riportare tutte le
indicazioni in lingua italiana e, qualora riportate anche
in altre lingue, le indicazioni in italiano dovevano avere
dimensioni maggiori di quelle riportate in altre lingue.
La disposizione, contestata dai servizi della Commissione
CEE, in quanto non prevista dalle norme comunitarie in
materia, non figura nel decreto legislativo n. 109. Questo
è al riguardo molto più preciso ed offre
un gran contributo alla libera circolazione comunitaria
dei prodotti alimentari che, anche se fabbricati in Italia,
riportano diciture non in lingua italiana, perché
di uso generalizzato e noto, oppure perché non
hanno un corrispondente termine in lingua italiana. Tali
diciture si riferiscono quasi esclusivamente alla denominazione
di vendita e al nome di taluni ingredienti, nonché
a nomi o ragioni sociali e sedi di fabbricanti, confezionatori
o venditori di altri Paesi. Talune denominazioni di uso
corrente intraducibili in lingua italiana sono contemplate
dai regolamenti comunitari relativi alle bevande spiritose
(regolamento del Consiglio n. 1576/89/CEE).Risultano inoltre
intraducibili i nomi di taluni prodotti tipici o a denominazione
di origine, qual, Emmenthal, Camembert. Giova infine evidenziare
che talune regole di etichettatura, per quanto riguarda
la lingua da utilizzare, sono da applicarsi non solo nella
lingua italiana, ma anche nell'esportazione. Non bisogna
dimenticare infatti che si tratta di regole che sono applicate
in tutta la CEE. A volte sfugge che l'obbligo di indicare
nello stesso campo visivo la denominazione di vendita,
la quantità netta o nominale, il termine minimo
di conservazione o la data di scadenza ed il titolo alcolometrico
volumico va rispettato in tutte le lingue ufficiali dei
Paesi ove il prodotto è posto in vendita.
Una delle indicazioni particolari che
devono essere riportate in etichetta è il termine
minimo di conservazione e la data di scadenza. La durabilità
dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa
mediante l'indicazione della data di scadenza per i prodotti
rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico
e dal termine minimo di conservazione per tutti gli altri.
Alle date suddette è stata data una precisa definizione,
con significato sostanzialmente diverso.
La data di scadenza è una specie
di ordine per il consumatore: il prodotto deve essere
consumato entro il giorno indicato sulla confezione, altrimenti
va buttato.
Il termine minimo di conservazione, invece,
fornisce un'informazione sulla ottimalità del prodotto,
se questo è mantenuto in adeguate condizioni di
conservazione. Ciò significa che alla data indicata
sulla confezione il prodotto può ancora possedere
le specifiche caratteristiche e non essere considerato
pericoloso per la salute umana. Il termine minimo di conservazione
non indica, al contrario, un termine di scadenza, in quanto
"minimo", ma la data fino alla quale il prodotto mantiene,
in adeguate condizioni di conservazione, le sue proprietà
specifiche. La garanzia offerta dal fabbricante o dal
confezionatore è una garanzia minima che va ben
oltre l'esigenza della commestibilità, in quanto
le proprietà specifiche sono soprattutto quelle
organolettiche. Con questo si vuole evidenziare che un
prodotto esposto nei banchi di vendita il giorno dopo
o alcuni giorni dopo la data indicata sull'imballaggio
non deve assolutamente creare allarmismi nel consumatore,
né tanto meno fare scattare immediatamente sequestri
per una presunta pericolosità; è evidente
che, di fronte a tale situazione, gli organi di vigilanza
debbano adottare i necessari accorgimenti per evitare
che si commettano abusi. Essendo il termine minimo di
conservazione una data indicativa, la differenza di tempo
tra la data indicata sull'etichetta e la permanenza del
prodotto nei banchi di vendita va verificata caso per
caso, prodotto per prodotto, a seconda della durabilità
dello stesso e sempre che il consumatore non sia tratto
in inganno.
La durabilità del prodotto alimentare
è determinata dal fabbricante o dal confezionatore
in base alle caratteristiche merceologiche del prodotto
stesso, ai trattamenti ai quali è stato sottoposto,
al materiale usato per il confezionamento e ad altri particolari
parametri, a meno che non sia espressamente previsto diversamente
da specifiche disposizioni, come nel caso dei diversi
tipi di latte di cui alla legge 3 maggio 1989 n. 169.
L'espressione da usare per l'indicazione
del termine minimo di conservazione è vincolante
ed è la seguente: "da consumarsi preferibilmente
entro" seguita dalla data oppure dall'indicazione del
punto dell'etichettatura ove essa figura. L'espressione
da usare per l'indicazione della data di scadenza è
anch'essa vincolante ed è la seguente: "da consumarsi
entro" seguita dalla data oppure dall'indicazione del
punto di etichettatura dove essa figura. La data deve
essere indicata sempre in chiaro e con le modalità
che si ritengono più idonee, purché sia
rispettato l'ordine seguente: giorno, mese ed anno. Non
è consentito usare espressioni o termini diversi
da quelli suddetti, anche se sortiscono lo stesso risultato.
Un'espressione del seguente tipo è vietata, pur
dando al consumatore l'informazione precisa: "data di
scadenza 18 luglio 1992"; l'espressione corretta è
"da consumarsi entro il 18 luglio 1992". Un'altra espressione
errata è la seguente: "prodotto il 18 luglio 1992
- da consumarsi preferibilmente entro due anni". Non sussistono
problemi nell'indicare la data di produzione, ma il termine
minimo di conservazione va sempre riportato con la dicitura
suddetta, e cioè: "prodotto il 18 luglio 1992 -
da consumarsi preferibilmente entro il 1994, ovvero entro
luglio 1994".
La data, poi, può essere espressa
a) senza l'indicazione dell'anno per
i prodotti conservabili almeno tre mesi. Esempio: "da
consumarsi entro il 10 luglio";
b) senza l'indicazione del giorno per
i prodotti conservabili più di tre mesi e non più
di diciotto mesi. Esempio: "da consumarsi preferibilmente
entro novembre 1992";
c) senza l'indicazione del giorno e del
mese per i prodotti conservabili per oltre diciotto mesi.
Esempio: "da consumarsi entro il 1995".
Nel definire la durabilità di
un prodotto conservabile per oltre diciotto mesi, indicando
solo l'anno, occorre prestare molta attenzione alla durabilità
effettiva, in quanto la mancanza del mese potrebbe attribuire
al prodotto una durabilità di gran lunga superiore
a quella effettivamente considerata dal fabbricante o
dal confezionatore. Si prenda, ad esempio, un prodotto
la cui durabilità è stata calcolata in due
anni (24 mesi) e che viene fabbricato e confezionato il
20 gennaio 1993. La dicitura "da consumarsi preferibilmente
entro il 1995" indica che il prodotto può essere
venduto almeno fino al 31 dicembre 1995, mantenendo le
caratteristiche specifiche. Nella realtà, il fabbricante,
non volendo offrire una garanzia superiore a due anni,
dovrebbe indicare, oltre all'anno, anche il mese, usando
la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro gennaio
1995".
Qualora per particolari esigenze di controllo
sia prescritto l'obbligo di indicare la data di produzione,
come nel caso della carni lavorate stagionate, il termine
minimo di conservazione deve figurare sempre con le formule
suddette. Qualora infine, in funzione della natura del
prodotto, siano necessari particolari accorgimenti per
garantire la conservazione del prodotto sino alla data
indicata sull'etichetta, ovvero nel caso in cui tali accorgimenti
siano espressamente prescritti da disposizioni specifiche,
l'indicazione del termine minimo di conservazione deve
essere completata dalla enunciazione delle condizioni
di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura
in relazione alla quale è stato determinato il
periodo di validità del prodotto. Per il latte
fresco pastorizzato, ad esempio, non è sufficiente
indicare la data di scadenza (4 giorni), ma occorre anche
evidenziare che essa è valida se il latte viene
conservato al fresco o nel frigorifero ad una temperatura
non superiore a + 4 °C. Per i prodotti surgelati le specifiche
disposizioni (decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 110)
dettano precise regole di indicazione delle condizioni
di conservazione.
L'indicazione del lotto, anche se già
prescritta per taluni prodotti alimentari quali i surgelati,
rappresenta una novità nella legislazione nazionale.
Essa risponde essenzialmente a due esigenze:
a) assicurare una migliore informazione
sulla identità dei prodotti alimentari: in questo
senso la menzione rappresenta la fonte di informazione
più utile ed efficace quando i prodotti stessi
sono oggetto di controversie negli scambi commerciali
nazionali ed internazionali, ovvero presentano un pericolo
per la salute umana.
b) proteggere il produttore o il confezionatore
o, in ogni caso, l'operatore responsabile, il quale, nel
caso di contestazioni (peraltro non rare) sulle caratteristiche
dei prodotti da parte dei settori della distribuzione,
degli importatori ed altri, si vedrebbe respinte solo
le quantità contestate riportanti quel determinato
lotto e non tutta la produzione. In mancanza, i danni
che gli operatori potrebbero subire sarebbero senz'altro
rilevanti.
Il lotto viene definito come l'insieme
delle unità di vendita di un prodotto alimentare,
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche. La definizione stessa di lotto presuppone quindi
l'esistenza di "un insieme di unità di vendita"
di un prodotto alimentare e non di singole unità
a se stanti. Nel caso di latte o di vino trasportato in
cisterne provenienti da aziende agricole e destinati a
centri di lavorazione o di imbottigliamento, non ricorrono
le condizioni per l’identificazione del lotto e, quindi,
non è richiesta la relativa indicazione sui recipienti.
La direttiva CEE n. 89/396 ha espresso questo concetto
in termini precisi: la definizione di lotto implica che
varie unità dello stesso prodotto alimentare presentino
caratteristiche praticamente identiche di produzione,
fabbricazione e condizionamento e tale definizione non
potrebbe pertanto applicarsi a prodotti presentati alla
rinfusa o che non possono essere considerati come un insieme
omogeneo per il loro carattere eterogeneo o la loro specificità
individuale. La dicitura del lotto va apposta sulle unità
di vendita e queste, secondo la destinazione, possono
essere imballaggi o preimballaggi. Ciò significa,
nel caso di un cartone di olio extra vergine di oliva,
che l'unità di vendita può essere il cartone
(imballaggio), ovvero le singole bottiglie o lattine di
olio contenute nell'imballaggio.
L'indicazione della sede dello stabilimento
di fabbricazione o di confezionamento è una menzione
alla quale negli altri Stati membri viene data poca importanza,
mentre in Italia è considerata di particolare interesse:
è infatti ritenuta utile soprattutto quando vengono
commercializzati, col solo nome del distributore, prodotti
tipici.
Di particolare interesse per i consumatori
sono le istruzioni per l’uso. Queste rappresentano un
messaggio, un’informazione che il produttore o il confezionatore
danno al consumatore, quando c'è l'effettiva esigenza
che il prodotto debba essere usato in un modo determinato
per trarne la massima soddisfazione. Anzi è proprio
il produttore ad avere interesse a fornire tale indicazione,
onde consentire al consumatore di conoscere ed apprezzare
la bontà del prodotto in parola. Sulla base di
tale considerazione è il produttore che valuta
se e quando le istruzioni per l'uso sono necessarie. I
casi, ovviamente, sono limitati.
In via generale sono necessarie le istruzioni
per l'uso per le polveri da tavola, per i preparati o
semilavorati (preparati per pizza), per i quali il consumatore
ha bisogno delle istruzioni per usare in modo corretto
il prodotto. Tale dicitura può essere considerata
utile altresì in alcune ricette culinarie, quando
servono informazioni sul tipo e la qualità degli
ingredienti da usare nella preparazione di un prodotto,
nel caso di sostanze che si prestano meglio di altre allo
scopo (esempio: un particolare tipo di olio). Si tratta
in ogni caso di un'esigenza che avverte anzitutto il produttore,
il quale è consapevole che per vendere deve anche
fornire al consumatore le notizie e le informazioni necessarie,
oltre a quelle obbligatorie, perché questi acquisti
ed utilizzi nelle migliori condizioni il prodotto.
Le indicazioni obbligatorie devono essere
apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili e non devono
in alcun modo essere dissimulate o deformate. Esse possono
essere riportate su un’etichetta, sul contenitore o sulla
confezione, su anelli, fascette, collarini, tappi e possono
figurare anche ripartite in più punti: alcune sul
tappo, ad esempio, altre sull'etichetta. L'unica menzione
che può figurare in codice è quella relativa
al lotto. Occorre poi prestare molta attenzione, nei negozi
di vendita, nell'applicazione di ulteriori etichette o
dei talloncini dei prezzi, che deve essere effettuata
in modo da non occultare, sia pure involontariamente,
talune indicazioni obbligatorie. Un talloncino, ad esempio,
apposto su una confezione di yogurt sull'indicazione del
termine minimo di conservazione potrebbe dare all'acquirente
l'impressione che la data di scadenza sia stata coperta
volontariamente perché prossima alla scadenza.
La denominazione di vendita, la quantità,
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
secondo i casi e il titolo alcolometrico, ove previsti,
devono figurare nello stesso campo visivo. Il decreto
non dà la definizione di campo visivo. Tuttavia
per esso deve intendersi la parte della confezione o dell'etichetta
su cui sia possibile leggere con un solo colpo d'occhio
le indicazioni suddette. Nel caso di confezioni a più
facce (scatole di pasta o di riso) le indicazioni possono
figurare anche sulla faccia più piccola. Il decreto
infatti si limita a prescrivere solo l'obbligo della indicazione
nello stesso campo visivo, ma nulla prescrive circa il
punto della confezione o dell'etichetta ove far figurare
le suddette menzioni. Detto obbligo non si applica fino
al 30 giugno 1999 alle bottiglie di vetro destinate ad
essere riutilizzate e sulle quali è impressa in
modo indelebile una delle suddette quattro menzioni. L'esenzione,
quindi, riguarda le bottiglie, a prescindere dal prodotto
alimentare che vi è contenuto.
Le bottiglie di vetro destinate ad essere
riutilizzate e sulle quali è riportata in modo
indelebile una dicitura e su cui quindi non è apposta
etichetta, fascetta o altro, nonché i preimballaggi
la cui superficie piana più grande sia inferiore
a 10 centimetri quadrati possono riportare solo le seguenti
indicazioni: denominazione di vendita, quantità
e termine minimo di conservazione o data di scadenza secondo
i casi.
Per la vendita al dettaglio dei prodotti
sfusi e dei prodotti venduti previo frazionamento anche
se originariamente preconfezionati, è stato mantenuto
l'obbligo del cartello applicato al comparto ove i prodotti
sono esposti per la vendita o ai recipienti che li contengono,
sul quale devono essere indicate le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti, ove prescritto;
c) le modalità di conservazione
per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico,
ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche;
e) il titolo alcolometrico volumico per
le bevande che hanno un contenuto di alcool superiore
a 1,2% in volume.
Questo tipo di vendita è stato
più volte oggetto di contestazioni, per la presunta
mancanza sui documenti commerciali di una o più
indicazioni, quali il termine minimo di scadenza e le
modalità di conservazione. Nei negozi di vendita,
pertanto, alla luce di quanto sopra, sul cartello devono
figurare le suddette indicazioni (articolo 16, comma 1)
con le modalità e le condizioni per esse stabilite,
mentre sui documenti commerciali relativi agli stessi
prodotti devono figurare le indicazioni di cui allo stesso
articolo 16, comma 8. Come si vede, sui documenti commerciali
non è richiesta l'indicazione della data né
delle modalità di conservazione, mentre sul cartello
l'indicazione della data è richiesta solo per le
paste fresche e le modalità di conservazione, ove
necessarie, solo per i prodotti molto deperibili. L'esigenza
di quest'ultima indicazione va verificata caso per caso,
con raziocinio. Per i prodotti di pasticceria artigianale,
ad esempio, considerato il loro consumo giornaliero, essendo
generalmente prodotti freschi, il consumatore sa come
comportarsi: non v'è quindi la necessità
di evidenziare tale indicazione. Anche per i gelati artigianali,
venduti generalmente in coni, in quanto prodotti di immediato
consumo, non v'è tale necessità. Per i prodotti
della pasticceria, della gelateria e della panetteria,
poi, gli ingredienti possono essere riportati su un unico
cartello ben esposto, sempre in ordine ponderale decrescente,
non per singoli prodotti della categoria (gelati al caffè,
gelato alla fragola, gelato alla crema, gelato al pistacchio,
ecc.), ma per categoria merceologica: un elenco unico
per tutti i gelati, un altro per la pasticceria fresca,
un altro ancora per i prodotti di panetteria, in quanto
da considerarsi come un gruppo omogeneo. Si tratta in
altri termini di fornire al consumatore la lista degli
ingredienti, additivi compresi, che generalmente sono
utilizzati per la preparazione di tali prodotti. Per i
prodotti della gastronomia è stato poi previsto
che l'elenco degli ingredienti possa essere riportato
su un registro o quaderno o altro mezzo, messo ben in
vista, a disposizione del consumatore in prossimità
dei banchi di vendita. Per la birra alla spina, infine,
è importante notare che le menzioni da evidenziare
(denominazione di vendita e titolo alcolometrico) possono
figurare su un cartello posto accanto all'impianto, ovvero
sull'impianto stesso, mediante collarino o altro mezzo.
I prodotti alimentari esposti per la
vendita al consumatore devono recare, oltre all'indicazione
del prezzo di vendita, anche l'indicazione del prezzo
per unità di misura, cioè il prezzo valido
per 100 g o 100 ml, ovvero per kg o l, secondo che il
prodotto è venduto per unità di massa o
di volume. Il prezzo per unità di misura, detto
anche prezzo unitario, va riferito alla quantità
netta o nominale indicata sull'etichetta, ovvero, nel
caso di prodotti che riportano l'indicazione della quantità
di prodotto sgocciolato, al peso netto del prodotto sgocciolato.
Esso può essere riferito a 100 g o 100 ml, se la
quantità non supera tali valori.
Esempi:
- per una confezione di yogurt da 125 g posta
in vendita a lire 1.100, oltre all'indicazione del prezzo
di vendita (lire 1.100) occorre indicare anche il prezzo
riferito al chilogrammo (lire 8.800), essendo la confezione
superiore a 100 g;
- per una tavoletta di cioccolato da 60 g posta
in vendita a lire 1.500, oltre all'indicazione del prezzo
di vendita (lire 1.500) occorre indicare il prezzo unitario
riferito a 100 g, trattandosi di confezione di peso
inferiore a 100 g (lire 2.500);
- per un barattolo di pomodori pelati avente peso
netto di 800 g e peso del prodotto sgocciolato di 480
g (60% di 800 g ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428), posto in vendita
a lire 960, il prezzo unitario va riferito alla quantità
di prodotto sgocciolato (480 g) che risulta di lire
2.000 al chilogrammo.
L'onere dell'indicazione del prezzo ricade
su chi fissa il prezzo di vendita ed espone i prodotti
per la vendita, in pratica sul commerciante ed eventualmente
sul fabbricante o sul confezionatore, nel caso questi
indichino sull'etichetta il prezzo di vendita dei loro
prodotti. Il venditore però, se modifica detto
prezzo di vendita, deve adeguare di conseguenza anche
il prezzo unitario.
Il prezzo unitario va indicato con le
stesse modalità stabilite per l'indicazione del
prezzo di vendita, cioè sull'etichetta del prodotto,
sui cartelli, sui banchi di vendita.
Talune categorie di prodotti sono esentate
dall'obbligo del prezzo unitario. Esse sono enumerate
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982 n. 903, come sostituto dell'articolo 2
del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 76:
a) prodotti preconfezionati per i quali
non è obbligatoria l'indicazione della quantità.
Si tratta dei
- prodotti soggetti a notevoli cali di massa
o di volume, che sono generalmente pesati alla presenza
dell'acquirente: questi infatti può visionare
il prezzo unitario direttamente dallo strumento
di misura;
- prodotti di cacao e di cioccolato di peso
inferiore a 50 g;
- prodotti dolciari, diversi da quelli di
cacao e cioccolato, di peso non superiore a 30 g;
- prodotti la cui quantità sia inferiore
a 5 g o 5 ml, salvo spezie e piante aromatiche;
b) prodotti di diversa natura posti in
una stessa confezione: ne sono esempio i cesti natalizi,
contenenti prodotti eterogenei;
c) prodotti commercializzati sfusi che
possono essere venduti a pezzo o a collo. L'articolo 10
del decreto ministeriale 21 dicembre 1984 (regolamento
di esecuzione della legge 5 agosto 1981 n. 441 sulla vendita
a peso netto delle merci) definisce la vendita a pezzo
e la vendita a collo e stabilisce le condizioni per tali
vendite;
d) prodotti distribuiti mediante apparecchi
automatici, in quanto assimilati ai prodotti venduti a
pezzo;
e) alimenti precucinati o preparati o
da preparare contenuti nello stesso imballaggio. La disposizione
individua tre categorie di prodotti (precucinati, preparati
da preparare) costituiti da più componenti, senza
peraltro darne la definizione. Tuttavia il ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, con propria circolare
n. 30101/C del 19 marzo 1986, ha fornito i seguenti criteri
per l'individuazione dei prodotti in parola:
- alimenti precucinati: sono gli alimenti
che hanno subito un trattamento termico non volto
alla mera conservazione, ma avente anche finalità
gastronomiche (ad esempio la precottura) e che inglobano
una quota di servizio che limita, totalmente o parzialmente,
l'intervento del consumatore;
- alimenti preparati: sono gli alimenti, complessi
ed elaborati, pronti per il consumo diretto, che
non necessitano di alcun intervento da parte del
consumatore in quanto inglobano un servizio totale;
- alimenti da preparare: sono gli alimenti
che hanno bisogno di un intervento di manipolazione
e di preparazione da parte del consumatore al fine
di ottenere un prodotto complesso o, comunque, più
elaborato di quello di partenza. In tal caso l'alimento
di base rappresenta un contributo, sotto forma di
servizio, che elimina una serie di operazioni preparatorie
per l'utilizzatore.
f) gelati monodose (non rientrano in
tale categoria le confezioni multiple di gelati);
g) prodotti di fantasia: la dizione è
troppo generica, ma non è difficile trovare dei
criteri che consentano di individuare tali prodotti. Deve
essere rilevante soprattutto l'apporto della fantasia,
necessaria a conferire al prodotto un'esclusività,
una particolare forma o preparazione, ecc. Tali prodotti,
pertanto, non sono paragonabili o confrontabili con altri,
per cui l'indicazione del prezzo unitario risulta poco
significativa. Rientrano in tale categoria di prodotti,
ad esempio, taluni tipi di pane con particolari realizzazioni,
uova pasquali di cioccolato, figurine e sigarette di cioccolato;
h) prodotti preconfezionati a gamme unitarie
costanti secondo valori di quantità o di capacità
stabilite da norme comunitarie. Rientrano in tale categoria
i prodotti elencati all'allegato 1 del decreto legge 3
luglio 1976 n. 451 e all'allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982 n. 825, lo zucchero, gli
estratti di caffè e le tavolette di cioccolato;
i) prodotti preconfezionati contemplati
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980 n. 391, posti in imballaggio collettivo ma destinati
ad essere venduti singolarmente, nonché i prodotti
preconfezionati elencati negli allegati del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 871, posti
in imballaggi collettivi ma destinati ad essere venduti
singolarmente e a condizione che per essi sia prevista
l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo unitario;
l) prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti previste da norme vigenti e che non
corrispondono a valori comunitari, nonché prodotti
preconfezionati a gamme unitarie costanti corrispondenti
ai seguenti valori espressi in g o ml: 100, 250, 500,
750, 1000 1500, 2000. Per questi prodotti l'esenzione
è concessa fino al 7 giugno 1995.
L'obbligo dell'indicazione del prezzo
unitario, infine, non si applica ai prodotti somministrati
al pubblico e a quelli destinati ad usi professionali.
LA PUBBLICITÀ
Il consumatore viene spesso bombardato
da messaggi subliminari che, consapevolmente od inconsapevolmente,
lo spingono a preferire determinati alimenti ad altri,
a prescindere da ragioni effettive. E’ per questo che
il legislatore, comunitario e nazionale, ha introdotto
una disciplina della pubblicità che cerchi, per
quanto possibile, di tamponare l’effetto suggestivo che
molti messaggi pubblicitari provocano. Spetta, però,
al consumatore guardare al di là dell’involucro
o dei messaggi lanciati dai mass media per operare la
propria scelta di acquisto in maniera consapevole.
La legge di riferimento in materia di
pubblicità è il D.Lgs. 72/92, la cui finalità
è quella di tutelare commercianti, produttori e
consumatori dalla pubblicità ingannevoli.
Per pubblicità si intende "ogni
tipo di messaggio diffuso da chi esercita attività
commerciali allo scopo di promuovere vendita, costruzione,
trasferimento di diritti -relativa a beni mobili ed immobili-
nonche' alla prestazione di servizi".
Il primo principio è quello in
base al quale la pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta, cioè non deve essere "ingannevole".
La pubblicità viene considerata ingannevole se
induce in errore i destinatari cui e' rivolta (sia per
contenuto che per presentazione), pregiudicando potenzialmente
il comportamento -economico- del consumatore finale o
determinando un danno nei confronti di un concorrente.
La pubblicità deve essere, inoltre,
riconoscibile in quanto tale.
Il messaggio pubblicitario diffuso a
mezzo stampa dovrà essere distinguibile dagli altri
testi, rendendolo chiaramente percettibile ed inconfutabile
nella sua natura grazie a grafica ed espressività.
I termini "garanzia" e "garantito" (e
simili) possono essere utilizzati solo se accompagnati
da chiare precisazioni su contenuto e modalità
della garanzia offerta.
Se la brevità del messaggio non
consentisse di riportare integralmente queste informazioni,
dovrà esserci un rimando sintetico ad un testo
-facilmente reperibile dal consumatore- con queste informazioni.
La pubblicità subliminale e' vietata.
Un caso particolare
relativo a prodotti considerati tossici
o comunque con possibile rischio per salute e sicurezza
dei consumatori. La pubblicità e' ingannevole se
non informa sulla presenza di questi prodotti, perche'
il consumatore potrebbe non seguire particolari regole
di prudenza e vigilanza.
La pubblicità per bambini ed adolescenti
per non essere ingannevole deve evitare
di minacciare la loro sicurezza e, in particolare, non
deve abusare della loro naturale credulità e mancanza
di esperienza.
L'uso di bambini e adolescenti
non e' consentito -nei messaggi diretti
agli adulti- per suscitare in chi guarda emozioni e decisioni,
approfittando della commozione e dei sentimenti che negli
adulti suscitano i piu' giovani.
L'Autorità
Con l'art.10 della Legge 10/10/90, n.287
e' stata istituita l'Autorità per la Concorrenza
ed il Mercato, alla quale possono essere inoltrate richieste
di vietare pubblicità ingannevole (o la sua continuazione).
Il suo intervento puo' essere chiesto da:
- singoli cittadini, o gruppi degli stessi
- ministero dell'Industria
- associazioni
- amministrazioni.
Per segnalazioni, rivolgersi a: Garante
per la Concorrenza ed il Mercato-Antitrust /Via Liguria
26, 00187 Roma, tel.06481621, fax 0648162256 http://www.agcm.it
I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE: CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
Come precedentemente accennato, è
recentemente entrato in vigore, anche in Italia, un D.Lgs.
(il D.Lgs. 155/97) che ha introdotto l’obbligo per "…ogni
soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro,
che esercita una o più delle seguenti attività:
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa
la somministrazione, di prodotti alimentari" (Articolo
2, comma 1, lettera b D.Lgs. 155/97) di attuare il c.d.
Autocontrollo Igienico, sulla base del metodo H.A.C.C.P.
(Hazard Analisys and Critical Control Point). Si tratta
di una vera e propria novità nel sistema italiano,
in quanto segna il passaggio da un metodo di controllo
ufficiale e repressivo, attuato dagli organi di controllo
(ASL, NAS ecc.), ad un sistema di autocontrollo preventivo,
messo in atto e gestito dallo stesso esercente. In pratica
questo significa che ogni ristorante, ogni dettagliante
alimentare, ogni produttore di alimenti ecc. deve predisporre
un vero e proprio Manuale (detto Manuale Aziendale di
Autocontrollo Igienico), in cui avrà descritto
la propria attività ed avrà individuato
i propri punti di controllo critici, c.d. CCP, su cui
effettuare il proprio monitoraggio. Egli, inoltre, individuati
i CCP, dovrà prevedere un vero e proprio sistema
di monitoraggio di dati (ad esempio registrazione quotidiana
delle temperature di frigoriferi e celle frigorifere,
registrazione degli interventi di sanificazione ecc.).
Non solo: sarà cura del titolare dell’attività
programmare ed attuare un sistema di "verifica", atto
a costituire banco di prova della funzionalità
e del corretto funzionamento del sistema di autocontrollo
predisposto, che potrà anche significare sottoporre
gli alimenti a controlli microbiologici di laboratorio.
Tale normativa è entrata definitivamente
in vigore in aprile 2000 e, come già accaduto in
passato, sono ancora moltissimi gli imprenditori che non
si sono adeguati.
Bisogna poi sottolineare che la normativa
ha come destinatari non solo le aziende di produzione
propriamente dette, ma anche il panettiere, il piccolo
market, il venditore ambulante e persino chi vende occasionalmente
ed a mero titolo gratuito generi alimentari: l’applicazione
a 360° è fondamentale se si vuole garantire il
mantenimento di quella "catena di controlli" che dovrebbe
garantire la salubrità degli alimenti giunti al
consumatore finale.
Inutile sottolineare l’opportunità
che il metodo H.A.C.C.P. sia attuato nelle mense scolastiche
e per quei generi alimentari comunemente consumati da
bambini e ragazzi, soprattutto se si considera che le
malattie alimentari sono più probabili, per la
delicatezza dell’organismo, in bambini ed anziani.
Sempre nell’ottica che quel che è
un obbligo per il produttore è un diritto per il
consumatore, non si può non sottolineare che ogni
cliente ha il diritto di veder rispettata questa normativa,
che porterebbe ad un sistema molto simile a quelli basati
sui più avanzati concetti di "qualità",
"certificazione di qualità" e "costumer satisfaction.
La stessa norma (come accennato precedentemente)
prevede una campagna di educazione alimentare, che rappresenta
l’ultimo stadio di questo sistema di autocontrollo: dal
produttore alla casalinga è necessario rispettare
dei comportamenti tali da poter garantire la propria salute
tramite la certezza che l’alimento preparato è
salubre.
Si riportano in allegato dei documenti
predisposti nell’ambito della campagna della sicurezza
alimentare.
In sintesi si può certamente affermare
che il D.Lgs. 155/97 è una di quelle norme che
hanno come scopo a medio-lungo termine quello di avvicinare
e rendere complementari l’interesse del produttore e del
consumatore.
ULTERIORI INFORMAZIONI
SULL'INTERESSANTE SITO
http://www.sicurezzalimentare.it
A cura della Dott.ssa
Rosa Barbano Di Maggio (esperto della Qualità
e della Sicurezza)
|